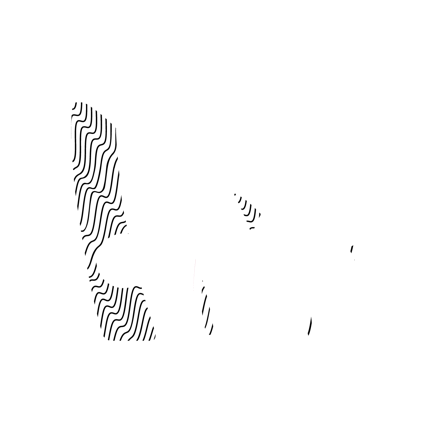Lo ammetto: sono a favore degli uffici fin lì.
Diciamo (lo so, è una statistica paracula) al 50%: da un lato ne riconosco valori fondamentali di socializzazione, ibridazione e osmosi, dall’altro trovo che tante esperienze vissute in ufficio siano altamente sostituibili da esperienze ibride o completamente virtualizzate. Più pratiche, silenziose, efficienti, dritte al punto.
Si tratta di una prospettiva, peraltro filtrata dal passare degli anni. In una delle prime esperienze lavorative, quando lo smart working era non esotico… di più 👽 collaboravo con un’agenzia in startup molto avanti per il tempo. Avevamo smart working totale per contratto e un hub piccolo ma spazioso (per 5 o 6 persone) all’interno di un coworking per chi aveva scatti di solitudine o nostalgia, nonché per ritrovarci a festeggiare di tanto in tanto o incontrare clienti e partner. Tanto che avevo accarezzato la possibilità di trasferirmi in UK con un amico, in puro stile work from anywhere. Ebbene, quella che oggi sarebbe a tutti gli effetti una condizione invidiabile, ricordo bene avermi procurato non più di un dubbio esistenziale.
A poco più di 20 anni il mio bisogno di conoscere, imparare, assorbire, era enorme, e non capivo se un’organizzazione aziendale di questo tipo avrebbe potuto aiutarmi o al contrario limitare la crescita.
Oggi il clima è molto diverso: la pandemia, la diffusione e l’arricchimento dei servizi offerti dalle piattaforme digitali e tanti altri fattori hanno enormemente accelerato i discorsi, le pratiche e i casi d’uso, verso modi diversi di collaborare e di creare valore. Forse, troppo diversi…
E tu, che washing sei?
Qualche mese fa, mentre correvo al parco, ascoltavo come sempre un podcast. Penso fosse di BCG, o di McKinsey, … non ricordo. Ricordo che mi era rimasto impresso perché la ricercatrice intervistata parlava di covidwashing: una parola che aveva inventato per indicare un utilizzo strumentale da parte delle aziende di tematiche o argomenti legati alla pandemia.
Purtroppo, pur cercandolo in rete, non ho mai ritrovato quel termine. In compenso greenwashing, pinkwashing, rainbowwashing, … sono etichette e pratiche che stanno vivendo una diffusione esponenziale. Anche in GreatPixel ne abbiamo parlato, approfittando di una riflessione sul wokewashing.
Come accennato, si tratta nel rendere cool e puramente cosmetico / superficiale un fenomeno invece importante, su cui bisognerebbe mettere la testa ed esplorare con senno. Tanto che H&M è stata recentemente citata in giudizio per il suo marketing sulla sostenibilità definito misleading. Prime reazioni al greenwashing insomma, che peraltro come italiani ci fa sempre più inorridire: secondo una recente ricerca The Fool, Brandwatch e GWI su dati Audiense, esso costituisce il primo disincentivo all’acquisto dei prodotti di un marchio per quasi un italiano su due (48%). Motivo per cui un’azienda davvero impegnata nella sostenibilità come Patagonia si guarda bene dall’usare la parola sustainable…
La pericolosa tendenza dell’officewashing
Ecco: queste ondate di washing stanno riguardando sempre più anche gli ambienti di lavoro. Non parlo solo di greenwashing, ma piuttosto intendo quello che potremmo immaginare e definire come officewashing.
L’officewashing è la nuova, potente retorica che sta impregnando e sporcando i discorsi sugli spazi lavorativi e i new ways of working.
In questi mesi ne ho lette di tutti i colori: dall’agenzia che ha nella propria sede addirittura delle piante per contribuire al benessere dei dipendenti (mannaggia, a saperlo prima… 😂) ai tanti lanci sul manager della felicità, anche detto chief happiness officer, che secondo un articolo pubblicato da La Stampa ridisegna la vita in azienda “tra calcio balilla e welfare”. 😟

Insomma, anche questa volta che Dio ce la mandi buona. Sperando che la retorica dell’officewashing finisca presto e senza lasciarsi dietro troppi danni.
Ovviamente non ho una soluzione sul come, non sono un esperto di questi temi ma semplicemente un osservatore curioso. Chiudo però con uno stimolo di lettura, un articolo di David Burkus ripubblicato da TED dal titolo affacinante: “Why a company is not a family — and how companies can bond with their employees instead”. Contiene anche una lista di impegni su cui, come persone che guidano team e aziende, mettere la testa: lavorare continuamente sul perché (purpose), dare maggiore importanza alla distinzione tra lavoro e le altre attività da fare nella giornata, celebrare le uscite dall’azienda senza far sentire in colpa la persona per essersene andata.
Punti facili sulla carta, molto più difficili da attivare per tanti motivi come tempi e risorse scarse, emozioni e nostri modi di essere che a volte hanno il sopravvento.
Buon lavoro!